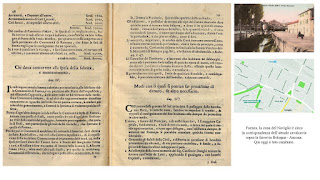Il collegamento attraverso l’Appennino
e con un canale da Faenza al mare
Ricerca di Claudio Mercatali
Pietro Maria Cavina era un notaio faentino del Seicento, appassionato di storia locale e per tanti anni amministratore della città e del suo territorio. Uomo con tanti interessi, scrisse molto e su temi diversi.
Questa che segue è una memoria indirizzata
“Agli illustrissimi Signori del Magistrato di Faenza del bimestre luglio – agosto 1683” dove tratta con dovizia di dettagli le possibilità di collegamento di Faenza con la Toscana e con Ravenna, considerando prima il collegamento attraverso l’appennino e poi un canale navigabile (il Naviglio) da Faenza all’ Adriatico.

L’antichissima strada Faentina
La via era praticata dai tempi dell’ antica Roma, anche se non era una strada consolare. Pietro Cavina la descrive fino a Firenze e considera anche le strade successive, da Pistoia a Lucca e a Pisa. Tutta questa viabilità fu devastata al tempo delle invasioni barbariche e rimase in abbandono per tanti secoli nel Medioevo.
Claudio Rutilio Namaziano (o Gallicano) nacque forse a Tolosa e fu Praefectus Urbis di Roma nel 414. Iniziò un viaggio verso la Gallia devastata dai Vandali, per verificare i suoi possedimenti, e lo descrisse nel diario De Reditu suo (Riguardo al suo ritorno). Parlò delle strade devastate dai Goti, fra le quali la Faentina, che non potè percorrere come aveva fatto altre volte, e fu costretto a viaggiare per mare lungo la Liguria. Ecco che cosa dice:
Ho preferito il mare, perché le vie di terra
piane sono invase dai fiumi e quelle alte bloccate dalle frane. Dopo che il territorio della Tuscia e dopo che la via di Aurelio hanno patito la spada e il fuoco dei Goti non c’è più un bosco abitato né un fiume con un ponte praticabile. Per l’incertezza è meglio affidarsi alla vela sul mare.
Spesso immaginiamo che sia da lasciar perdere l’apertura di una porta. Controvoglia i piedi oltrepassano le soglie dei templi .Chiediamo perdono con il pianto e recitiamo la preghiera.
Per quanto il lamento può permettere di pronunciare le parole …
Clicca sulle immagini per ingrandirle ed avere
una comoda lettura
Il moderno canale navigabile
Faenza è appena 35 metri sul livello del mare e già nel Seicento fu considerata l’idea di costruire un canale che la collegasse a Ravenna sfruttando le acque del Lamone regolate da una serie di chiuse.
Nel 1677 Pietro Cavina propose il Naviglio, ma non se ne fece niente, a causa della carestia e della peste che imperversavano in quegli anni.
Nel 1763 il progetto fu riproposto e affidato al conte Zanelli, che lo realizzò nel 1782. Quattro buoi sulle sponde trascinavano le chiatte cariche da Bagnacavallo a Faenza, mentre al contrario i navigli scendevano lentamente verso l’Adriatico sospinti dalla corrente dell’acqua prelevata dal Lamone.
Il sistema fu attivo nella prima metà dell’ Ottocento ma poi fu soppiantato dalle nuove tecnologie, ossia dalla ferrovia Faentina. Oggi rimangono solo le vestigia.
Leggiamo la proposta di Pietro Cavina.
La traccia del naviglio è il canale che costeggia la strada che porta da Faenza al casello dell' autostrada Bologna - Ancona.
Arrivava in città all' incirca in corrispondenza dell' attuale cavalcavia ferroviario e finiva dove ora ci sono i viali di circonvallazione, vicino alla Stazione delle Corriere.
Al contrario di quello che si potrebbe immaginare il Naviglio dopo Bagnacavallo evitava Ravenna e si snodava verso
Alfonsine e Sant'Alberto.
Ad Alfonsine sono presenti
delle interessanti vestigia.