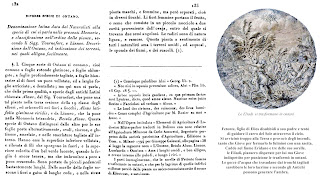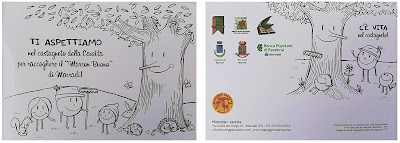pianta da riconsiderare
ricerca di Claudio Mercatali
La Plantaggine (Orecchietta)
Nel linguaggio comune le erbacce
sono quelle spontanee che crescono nelle aiuole dove vorremmo vedere solo le
eleganti rosacee, o nel prato sopra al trifoglio gentile e alle margherite.
Le
erbacce sono prolifiche, invadenti e bruttine, perciò a primavera le strappiamo
senza tanti complimenti e finiscono nel mucchio del compost o nello sfalcio.
Una tipica erbaccia è la Plantaggine, perenne perché dotata di rizoma.
Le
foglie sono parallelinervie a cinque strie. Alla base c'è una rosetta di foglie dalla quale spuntano le brattèe, cioè gli steli con le antère.
E' la tipica erba che si estirpa,
perché dà un senso di disordine e di abbandono al giardino. Però se la
consideriamo più attentamente si rivela interessante. Antibatterica, lenitiva
ed emolliente forse deve il suo nome al fatto che i pellegrini in viaggio verso
la Terrasanta la usavano come soletta per lenire il fastidio e il dolore delle
vesciche alla pianta dei piedi.

Può darsi anche che il nome venga
da "planta agere", pianta che fa crescere altre erbe, perché è poco
esigente e pioniera nei terreni calpestati parecchio dalle bestie al pascolo.
Nel Mugello ha il nome popolare di Orecchietta perché le sue foglie
assomigliano alle orecchie di una lepre.
Cresce in tutta l'Europa e il botanico Richard Mabey nel suo libro Elogio delle erbacce descrive così
quella inglese:
... La Plantaggine, "la
madre delle piante" è presente in quasi tutte le prime prescrizioni di
erbe magiche, addirittura fin dalle prime cerimonie celtiche del fuoco.
Non è chiaro perché questa scialba pianta, una semplice rosetta di foglie culminante in una infiorescenza a punta simile a una coda di topo, dovesse essere preminente ....
Prospera su strade, sentieri, scalini di chiese. Le sue foglie tenaci ed elastiche, che crescono al livello del suolo, resistono al calpestìo ...
i principi della magia simpatetica, perciò, indicavano l'efficacia della piantaggine in caso di contusioni e ferite. Era anche un'erba divinatoria,
che scorgeva il futuro e a quei tempi era usata nei periodi in cui la barriera
tra questo e l'altro mondo era sottilissima.
La vigilia di San Giovanni, nel
Berwichshire, gli steli fioriti erano impiegati dalle giovani donne per
prevedere se si sarebbero innamorate.
 Era un procedimento delicato, in
cui gli organi sessuali della Plantaggine venivano usati come indicatori
simbolici. Erano scelte due infiorescenze a "coda di topo" e private
di tutte le antere visibili (le punte
portatrici di polline).
Le infiorescenze erano avvolte in foglie e poste
sotto una pietra. Se il giorno dopo erano spuntate altre antere l'amore era in
arrivo ....
Era un procedimento delicato, in
cui gli organi sessuali della Plantaggine venivano usati come indicatori
simbolici. Erano scelte due infiorescenze a "coda di topo" e private
di tutte le antere visibili (le punte
portatrici di polline).
Le infiorescenze erano avvolte in foglie e poste
sotto una pietra. Se il giorno dopo erano spuntate altre antere l'amore era in
arrivo ....
Le foglie di plantaggine
sono pronte
La piantaggine e il timo si
trovano facilmente qui da noi nella tarda primavera ma non hanno lo stesso
habitat, cioè nascono in posti diversi. La Plantaggine è nei campi incolti e il
Timo, assieme all' Origano e alla Maggiorana predilige i prati pascolo ad erba
rasa, ai quali conferisce un sottile profumo di primavera.
Ci sono diverse ricette di
erboristeria che sfruttano il potere lenitivo e antinfiammatorio di queste
piante per combattere la tosse. La più semplice è uno sciroppo di acqua, miele,
Plantaggine e Timo, che ho preparato così:
 Clicca sulle immagini
Clicca sulle immagini
se le vuoi ingrandire
Per 125 ml (una bottiglietta
da succo di frutta) ho messo 360 mg di foglie di Plantaggine e 60 mg di Timo tritate in un
tegamino con poca acqua e ho riscaldato senza far bollire, mescolando spesso. Dopo mezz'ora ho sterilizzato un colino con acqua bollente e ho filtrato.

Ho aggiunto il miele a cucchiai
agitando per scioglierlo, fino a riempire la bottiglietta. La dose è un terzo di miele
e due terzi di infuso. Senza conservanti lo sciroppo non dura più di due settimane e quindi in casa si può fare solo per fare una prova di assaggio.
L'elegante infiorescenza
della Plantaggine
 Dopo l'aggiunta del miele
Dopo l'aggiunta del miele
Questo è quello che ho fatto. Però non sono un medico e non so dire se l'infuso faccia bene o male per la tosse o per qualche altro motivo.
 Chi vuole approfondire questo aspetto può trovare facilmente su internet tanti siti di erboristerie che preparano in modo sicuro questi infusi
Chi vuole approfondire questo aspetto può trovare facilmente su internet tanti siti di erboristerie che preparano in modo sicuro questi infusi.
Bibliografia: Richard Mabey,
Elogio delle erbacce (qui a fianco),editrice Ponte alle Grazie, disponibile
alla Biblioteca di Marradi.