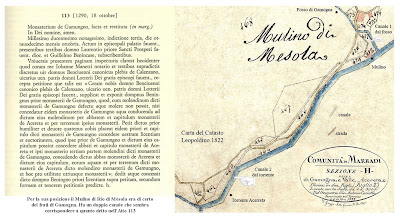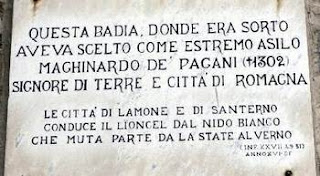I contratti fatti dai preti della nostra
I contratti fatti dai preti della nostra
zona di fronte al vescovo di Faenza
Ricerca di Claudio Mercatali
Nelle ricerche di storia medioevale una ricca serie di notizie si ricava
dagli atti notarili, che già allora descrivevano con dovizia di particolari le
persone, i luoghi e le cose. L’archivio notarile di Lottieri della Tosa,
fiorentino, vescovo a Faenza alla fine del Duecento è particolarmente
interessante per noi.
Che cosa faceva un vescovo fiorentino in Romagna in
quegli anni, con un seguito di notabili toscani suoi concittadini? Una breve
biografia di lui chiarirà i fatti:
Lottieri della Tosa di Odaldo nacque a Firenze alla metà del '200. Di
famiglia guelfa, nel 1287 divenne vescovo di Faenza con l'aiuto di Maghinardo
Pagani da Susinana, ghibellino ma legato alla Firenze guelfa per aver sposato
Rengarda Della Tosa. Non a caso Maghinardo per il suo ambiguo atteggiamento
politico fu definito da Dante "il leoncel dal nido bianco / che muta parte
da la state al verno" (Inferno, XXVII, 50-51).
Maghinardo con la
nomina di un vescovo di sua fiducia voleva rafforzare il suo dominio sulla
città che governò fino alla morte (1302) come Podestà o Capitano del Popolo. Il
30 settembre 1287 Lottieri della Tosa entrò solennemente in Faenza con un gran
numero di prelati e nobili fiorentini. Dal 1290 fu coinvolto nella rivolta
antipapale dei Comuni romagnoli, iniziata da Guido da Polenta di Ravenna e
dallo stesso Maghinardo. Quando i Comuni romagnoli firmarono il trattato di
pace del 1297 il vescovo annullò gli interdetti che aveva lanciato contro diverse città della Romagna nel corso della
rivolta. Nel febbraio del 1302, pochi mesi prima della morte di Maghinardo, suo amico e
protettore, Lottieri tornò a Firenze. Il suo ingresso in città fu
ancor più solenne di quanto non fosse stata, quindici anni prima, la sua
entrata a Faenza.
Ora
il vescovo Lottieri ci interessa perché ha lasciato un ricco Codice di carte
notarili, redatte in sua presenza dal notaio fiorentino Giovanni Manetti che Lottieri
aveva portato con sé a Faenza. Sono 224, ricche di notizie su chiese e
sacerdoti, ma un po’ difficili da leggere, perché il linguaggio notarile è di
per sé arido e per giunta qui è in un duro latino medioevale. Però in diversi
atti si parla della zona di Marradi e dunque andiamo a curiosare nelle faccende
personali dei preti nostri compaesani di quel secolo remoto:
Atto 9 A termini di
legge consegnato all’ interessato sacerdote Ugolino, da Giovanni Manetti notaio,
il 23 gennaio 1289.
Lottieri
vescovo di Faenza per grazia di Dio augura salute nel nome del Signore al
distinto sacerdote Ugolino rettore della chiesa di San Cassiano della Pieve di
Ottavo (la Pieve del Tho) della diocesi faentina e canonico della chiesa di
Popolano della detta diocesi. La
tua ammirevole devozione ci induce a riconoscerti una speciale grazia e favore.
E per questo con la presente disposizione ti concediamo che, non essendoci
nessuna nostra contrarietà, tu possa liberamente tenere per te i detti
benefici. Li presentiamo alle persone presenti apponendo su questo documento il
sigillo testimonio nostro. Fatto
in Faenza nel Vescovado alla presenza di frà Vita abate del monastero di Santa
Maria Fuori Porta e Ventura rettore della chiesa di San Simone di Faenza, e
altri. Anno 1289, 23 gennaio, seconda seduta.
NOTA Il Canonico fa parte del collegio che
celebra le messe più solenni nella cattedrale della diocesi. A quel tempo era
un incarico di prestigio dato a sacerdoti di chiese abbastanza importanti (San
Cassiano è una chiesa Arcipretale e Popolano una Priorìa).
Atto 38 Canonica di Popolano, fatto e
consegnato
26 marzo 1289
Redatto
sopra l’aula del vescovado faentino alla presenza degli anziani Monaldo e
Guidone di Luestano ed altri.
Don
Alberico, priore e canonico di Popolano della diocesi di Faenza, di fronte al
venerabile padre don Lottieri, per grazia di Dio vescovo di Faenza, chiese di
persona umilmente e in maniera devota il rinnovo per 28 anni di una licenza di
affitto del fratello Aspectato di Popolano per il figlio Farolfino, per un
casamento di detta canonica, posto vicino a detta canonica il quale confina con
: II la via, III la fontana, IIII la parte riservata di questa canonica, dietro
la promessa di dare ogni anno allo stesso priore e canonico un paio di capponi (unius paris caponis) per Natale. Udita
questa richiesta, vista e letta, il venerabile padre predetto concesse la
licenza secondo la forma della domanda predetta.
NOTE Negli atti notarili di questo tipo i confinanti sui quattro lati della proprietà
erano elencati con la numerazione I, II, III, IIII. Secondo il diritto Romano in
uso nel Medioevo la durata tipica dei contratti era di una generazione, cioè di
circa 29 anni.
Atto 56 Fatto in chiesa. Scomunica contro il
sacerdote Albertino di Monte Romano
13 giugno 1289
NOTA
L’Atto è scolorito e in certi punti si legge male.
In
nome di Dio amen
Noi
Lottieri vescovo faentino per grazia di Dio Ad 1289 … legittimamente facesse
citare, e anche ammonisse e requisisse don Albertino rettore della chiesa di Santo Stefano di Monte Romano pieve d’Ottavo … perché tornasse residente proprio
lì a detta chiesa di Santo Stefano e … era tenuto a celebrare gli offizi e per
questo come da noi asserito, con animo irato … si rifiutò e ancora rifiuta e si
vanta contento della sua disobbedienza … ammoniamo lui per la malizia,
l’assenza ingiustificata e la disobbedienza che mi è stata comunicata …
affinché questo sacerdote Albertino entro quindici giorni ritorni alla sua
chiesa di Santo Stefano e dimori lì e celebri i divini offici ai quali è
tenuto. Altrimenti se continuerà ad eludere la nostra ammonizione in questo
modo, che pubblicamente gli abbiamo fatto, procederemo contro di lui con la
rimozione dalla sua chiesa … multa ed altri provvedimenti di legge, come è invitato
per giustizia …
Questa
ammonizione fu detta e fatta in queste note su disposizione del venerabile
padre nel vescovado, sede del tribunale alla presenza dei testimoni don
Domenico … di Bagnacavallo, Lottario Benincasa, Cenni e Neri, con i famigliari
del detto venerabile e altri. Nell’ anno 1289, 13 giugno.
NOTA Don Albertino obbedì al vescovo? Non lo
sappiamo, però in altri contratti notarili successivi a questo compare il nome
di don Buono come rettore di Monte Romano.
Atto 74 6
luglio 1290 Assoluzione di don Ubaldino, priore di Popolano
Nel
nome di Dio, amen.
Redatto
sulle gradinate del vescovado di Faenza, alla presenza del chierico Pasquino,
di Lotario Benincasa e Cenni di Bartolo, con i sottoscritti famigliari del
venerabile padre (il vescovo) il notaio Mastonese e altri sottoscriventi.
NOTA Quella che segue è una lettera di Pietro
Saraceno vescovo e legato pontificio in Romagna, che scrive a Lottieri e lo
autorizza a sciogliere l’interdetto ai danni di Ubaldino, priore di Popolano, che non
aveva inviato l’elenco dei fumantes (i contribuenti) nei termini prescritti.
Pietro Saraceno precisa che la concessione è per fare un piacere al vescovo
Lottieri e soprattutto a Maghinardo Pagani, zio di Ubaldino.
Tutti
gli ispettori elencati in questa pagina prendono atto che davanti a me,
Giovanni Manetti notaio, con i testimoni sopradetti e il venerabile Lottieri
vescovo di Faenza è stata recapitata la lettera qui di seguito scritta:
“Venerabile in Cristo, padre e amico carissimo Lotterio, per grazia di Dio
vescovo di Faenza, Pietro per permesso divino vescovo di Vicenza, vicario
pontificio nella Provincia di Romagna, vi auguro la salute e la sincera carità
di Dio; abbiamo ricevuto le lettere che ci hai mandato, e volendo per richiesta
vostra annuire e compiacere il nobile uomo Maghinardo di Susinana in queste,
consegnamo la presente alla vostra autorità, poiché il priore canonico di
Popolano sia assolto dalla sentenza alla quale era incorso perché non presentò
a noi nel termine stabilito i fumantes della sua Priorìa … Dato
a Rimini, il giorno XXIIII giugno”.
Per
l’autorità che gli è stata conferita dal predetto Pietro vescovo di Vicenza,
don Ubaldino priore canonico sopra detto è assolto dalla predetta sentenza,
imponendogli una penitenza salutare.
Atto 80 Procura e vicariato per don Buono, consegnata
all’ interessato il 26 luglio 1290
NOTA
Abbiamo già incontrato don Buono, parroco di Monte Romano, nominato al
posto di don Albertino, il prete che non voleva risiedere nella sua chiesa. Ora don Buono è nominato rettore della chiesa di San Cassiano al
posto di don Ugolino, che parte “ultra mare per guerram Iesu Christi” (per la Crociata). Nel 1290 i Mussulmani assediarono San Giovanni d’Acri, la
capitale del Regno cristiano di Gerusalemme, che cadde nel 1291.
In
detto giorno e luogo e in presenza di detti testimoni, don Ugolino rettore
della chiesa di San Cassiano Pieve di Ottavo, Diocesi di Faenza, con il
consenso e la parola di don Bencivenni, vicario del venerabile padre don Lottieri
vescovo di Faenza per grazia di Dio, che intende avviarsi oltre il mare per la
guerra di Gesù Cristo, fece vice della sua chiesa, costituì e ordinò suo
procuratore, vicario ed economo in detta chiesa, don Buono rettore della chiesa
di Monte Romano, presente e consenziente, per le cose spirituali e temporali finché
egli non tornerà o Dio farà di lui altro …
…
e
il vescovo accettò con il mandato più ampio. Ugolino, che era anche
canonico di Popolano, tornò dalla Crociata? No, perché nel 1302 don Buono era
ancora rettore in sua vece.
Atto 113 Monastero di Gamogna, fatto e consegnato
18
ottobre 1290
Nel
nome di Dio, amen.
Atto scritto nel vescovado di Faenza alla presenza dei testimoni don Lorenzo priore di San
Prospero e Guglielmo Benincasa sottoscriventi.
A tutti quelli che hanno visionato questo scritto è risultato ben chiaro che davanti a me Giovanni Manetti notaio e con i testimoni sopra detti il discreto uomo don Bencivenni canonico della Pieve di Calenzano, vicario di Lottieri vescovo di Faenza ha ricevuto questa richiesta:“Don Benigno, priore del Monastero di
Gamogna spiega che per mancanza d’acqua non può macinare con il molino di detto
monastero se non viene concesso dall’ abate di Badia della valle di portare
acqua al suo molino attraverso i terreni del suo monastero. Il
detto priore di Gamogna chiede in modo umile e devoto di concedere il permesso
nel modo che a voi piacerà affinché possa cedere all’abate del monastero di
Acereta un terzo del molino di Gamogna se l’abate del monastero di Acereta
concederà la sua acqua e il passaggio per il terreno e questo a vantaggio di
ambedue i monasteri. Viene dato e concesso al detto don Benigno il permesso richiesto, secondo la forma e il tenore della richiesta sopra detta.
NOTA Questo è un tipico contratto di
livello, per concedere terre e diritti alle condizioni scritte in “duo
libelli pari tenore conscripti” (da qui il nome del contratto): due cartelle uguali e ogni contraente firmava quella che rimaneva in mano all' altro. Perciò abbinato a questo appena
letto c’è l'Atto 114 dell’abate di Acereta, cioè la sua
risposta.
Atto 114 Monastero di Acereta, fatto e consegnato
18
ottobre 1290
Agli ispettori che hanno visionato questo scritto è risultato ben chiaro che davanti a me Giovanni Manetti notaio e con i testimoni sopra
detti, il discreto uomo don Bencivenni canonico della Pieve di Calenzano,
vicario di Lottieri vescovo di Faenza ha ricevuto questa richiesta: “Il notaio
Dracone, procuratore di don Matteo abate di Acereta in modo umile e devoto
chiede il permesso di dare la loro acqua e il passaggio per i loro terreni ai
priore di Gamogna per il suo molino se il detto priore concederà la terza parte
del molino a compenso dell’acque e del terreno predetto ...
NOTA Il molino di cui si parla è quello di Rio di
Mèsola o forse quello di Ponte della Valle, non più attivi ma ancora esistenti.
Atto 203 Chiesa di Abeto, licenza consegnata
27 ottobre 1291
In
nome di Dio, amen
Fatto
nella sala del vescovado di Faenza alla presenza dei testimoni Peppo di Susciana
(Sessana?) plebato di Modigliana e Spunta figlio di Azzolino di Lutirano,
sottoscriventi. Don
Ugolino, rettore della chiesa di San Michele di Abeto, presentatosi a Lottieri,
vescovo di Faenza per grazia di Dio, chiese in nome della sua chiesa e in suo
favore, di dargli licenza per rinnovare a livello una locazione di ventotto
anni, di un certo molino della sua chiesa posto nel Rio di Stagnana, alle
migliori condizioni che potrà. Per questa ragione il venerabile padre predetto
udita la richiesta fatta, concesse e diede a don Ugolino la licenza secondo
quanto dichiarato.
NOTA Dov' è Susciana? Siccome il notaio Giovanni Manetti era fiorentino è probabile che abbia trascritto il nome Sessana con la "sc" data la nostra tendenza e pronunciare la "s" in modo pesante.
Per
ampliare
Lottieri della Tosa, di Massimo Tarassi Dizionario Bio. degli Italiani vol.
37 (1989)