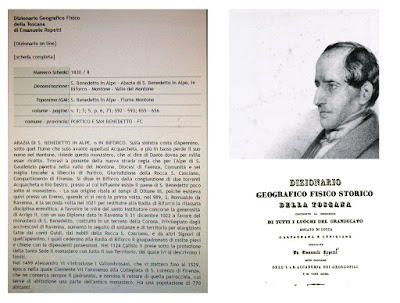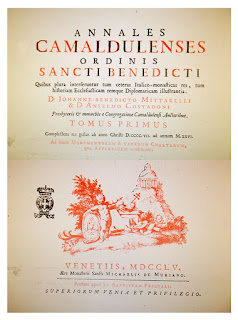Una disputa tra i frati
Ricerca di Claudio Mercatali
Il monastero di Camaldoli fu fondato da san Romualdo circa nell'anno Mille e nello stesso tempo san Gualberto fondò Vallombrosa. Sono ambedue conventi benedettini, ma separati. Però agli inizi del Settecento l'abate camaldolese Guido Grandi scrisse un libro per dimostrare che Vallombrosa era una filiazione di Camaldoli e dopo qualche anno il monaco vallombrosano Fedele Soldani ne scrisse un altro per dimostrare che non era vero. Era nata una disputa accanita, per una questione di prestigio ma anche di soldi perché la primogenitura di Camaldoli avrebbe portato a quel monastero più donazioni e lasciti e quindi più potere.
Guido Grandi era un abate visitatore, ossia ispettore di monasteri e anche lettore di filosofia nel monastero fiorentino di S. Maria degli Angeli, dove insegnava matematica, materia in cui divenne esperto, tanto che il granduca Cosimo III volle conoscerlo. Era sempre impegnato in questioni, polemiche e dispute.
Nella corrispondenza qui di seguito Orazio Mazzei, un monaco della Badia del Borgo di Marradi gli comunica che Fedele Soldani cerca di accattivarsi le simpatie del cardinale Aldobrandini. Soldani nelle sue Questioni istoriche cronologiche vallombrosane (Lucca 1731) negava che Vallombrosa fosse stata una filiazione della Congregazione camaldolese. Il Grandi gli aveva già contestato questo, con una dura lettera firmata con lo pseudonimo don Vitale Marzi e il Soldani gli aveva risposto per le rime. Orazio Mazzei, della Badia del Borgo, che parteggiava per Guido Grandi gli chiese una copia dei suoi libri da mandare al cardinale, in modo da smontare le tesi del suo rivale. Leggiamo:
All'illustrissimo padre visitatore Guido Grandi
monastero de' Camaldolesi Faenza
Come bene dice Antonio Lupis nella sua Segreteria Morale, che un uomo allor quando ha perso il rossore si rassomiglia al porco dritto, quale talmente ha indurito la pelle, che più non sente le percosse dei sassi. V.S. Ill.ma avrà cognizione mediante l'infamia della sua condotta del nostro religioso padre Fedele Soldani, Monaco Vallombrosano, che messosi a fronte di S.E. Ill.ma ha preteso con i suoi scritti, e stampe non solo di impugnare la di lei sapienza e Virtù ma di più biasimarla come apocrifa, e totalmente mendace. Questo medesimo religioso, vero geroglifico di una meretrice, che stimando gli atti più disonesti di una galanteria d'amore, si è presentato personalmente davanti alla Maestà del nostro Ministro Aldobrandini dignitosissimo protettore della nostra Congregazione e con i medesimi suoi libri a lui dedicati per ricevere da quello in premio qualche grado onorifico nella nostra Religione.
Io che amo assai la giustizia e sempre son tutto a favore del merito, ritrovandomi all'età di 68 anni molto sciente e consapevole del di lui primato e pubblico successo, vorrei reprimere appresso il medesimo porporato la di lui baldanza mezzo d'uno dei suoi virtuosi libri stampati da V.S. Ill.ma sotto il nome di padre Marzi, nei quali apparendo chiare le bugie del medesimo venefico soggetto, conoscesse l'inganno con il quale pretendeva allucinare la prudenza di un santo dignitosissimo cardinale. Mi onori dunque trasmettermelo avvisandomi la spesa, che io puntualmente soddisfacendo per via del vostro padre di Santa Umiltà gli resterò con quelle obbligazioni con cui vi dico:
Vostro obbligatissimo servo don Orazio Mazzei, monaco
Santa Reparata, Marradi 28 agosto 1733
Dopo tre giorni arrivarono a Marradi i libri e il monaco della Badia ossequioso ringraziò della considerazione ricevuta.
All'illustrissimo padre visitatore Guido Grandi
monastero de' Camaldolesi Faenza
M'accresce la sicurezza di aver luogo nella stimatissima grazia di Vostra Grazia Eccellentissima il ricevimento che fò oggi dei suoi dottissimi e bei libri per mano di un nostro lavoratore; ed essendo questa occasione per me una delle più considerabili contentezze stimo perciò infinitamente l'uffizio di dover io esser marrano per far spiccare appresso di sua Eccellenza Aldobrandini la di lei gloria, e nel medesimo tempo reprimere la baldanza di chi si voleva far conoscere qual alter Deus in materia di cronologia, del qual studio (a mio parere) non è se non alquanto infarinato. ..... il vero, a parere di Seneca le dignità a chi è degno di pena accrescono maggior esca al male, là dove la depressione gli mette al dovere e gli serve di freno che all'avventargli alle scellerataggini, chi non si adoprerà per reprimere la superbia di quello, che piccolino di merito pretende di farsi grande. Essendo dunque io amicissimo e buon servitore da qualche tempo della signora Sor Maria Teresa e Sor Maria Geltrude Aldobrandini, sorelle del medesimo Eccellentissimo porporato e degnissime monache della Crocetta di Firenze, perché faccino maggiore spicco i suoi libri, procurerò con ogni cautela e diligenza che per le mani loro gli venghino presentati da parte di Sua eccellenza Reverendissima;sarà poi mio pensiero accompagnargli con una lettera informativa del soggetto contraddittore per far conoscere a Sua Eccellenza se egli per tanto tempo che è stato presule della religione apostata e ramingo che sono stati sette anni possa e abbia potuto mai impratichirvisi e dei pubblici archivi e del privato della Nostra Congregazione a fine di farsi vedere alle stampe.
Nel rendere poi a vostra Eccellenza ossequiose grazie la supplico altresì di darmi qualche riscontro che gli siano stati accetti i sentimenti espressi con altra mia in ordine alle sue maggiori felicità, col farmi abbondante parte dei suoi comandamenti, mentre baciandole riverentemente le vesti, mi dico
suo obbligatissimo servo don Orazio Mazzei, monaco
da Santa Reparata, Marradi 31 agosto 1733
Il cardinale Aldobrandini, Legato Pontificio di Ferrara, in quei giorni si recò in visita a Faenza e quindi l'intervento del monaco della Badia era divenuto superfluo:
All'illustrissimo padre visitatore Guido Grandi
monastero de' Camaldolesi Faenza
Giungono qua a Marradi le nuove come l'eminentissimo Aldobrandini, Legato di Ferrara, sia per venire o per dir meglio sia già venuto costì nella città di Faenza ove tanto lei che il cardinale hanno le loro stanze e residenza, e io considerando di porgere al sopraddetto Prelato in opportuna occasione personalmente le sue opere gliele trasmetto con tutta la diligenza acciò abbia egli stesso quell'onore. Per dire il vero io volevo presentarglieli per me stesso personalmente nell'occasione di passar da Ferrara, andando alla sua casa di Governo, ma trattenendomi fino a Santa Reparata, festa di questa abbazia, dove siamo meschini monaci, mi è parso più a proposito per lei abboccarsi con Sua Eminenza che già conosce il soggetto descrittogli già dalla sua sorella monaca della Crocetta e da suo nipote don Fabio, i quali in Firenze hanno veduti, letti e commentati gli istessi libri. Intanto con tutta la vivezza del mio spirito potrò ringraziare il reverendo abate Guido, confermandole sempre più la mia volontà di servirlo, mentre nel pregare per Voi dal cielo ogni maggiore prosperità mi confermo col dirmi.
da Santa Reparata, Marradi 1ottobre 1733 don Orazio Mazzei, monaco
Al Reverendissimo don Guido Grandi Visitatore dei Camaldolesi
Credo che a quest’ora Vostra Signoria avrà terminato le sue fatiche nelle visite di sua Congregazione e secondo mi accennò il padre Mauri si sarà restituito alla sua quiete, e stanza, dove avrà trovato come si portò l’accidente propizio che il detto padre consegnasse in propria mano a S.E. Aldobrandini i suoi libri, al medesimo porporato molto graditi. Io me ne rallegro seco mentre ho conosciuto aver avuto buon fine i suoi virtuosi sudori. Come vedrà dall’inclusa io non mancai di cooperare a quel bando che gli promisi, di fargliene presentare per la sorella sua monaca, ma sapendo essere costì S.E. me gli feci rimandare e spediti a Faenza hanno sortito con tutta gloria il suo fine. Vedrà dall’inclusa stessa l’aver avuto la medesima religiosa gran gusto di vedergli e sentirà come il padre Soldani da Poppi con stravagante affettazione incensa Sua Eccellenza a fargli credere essere il corpo di San Pietro ligneo a Vallombrosa ed essere della sua famiglia. Io che ho passato il tempo di anni 40 nella mia religione e che più volte sono stato di famiglia a Vallombrosa so che per quante diligenze abbia fatto il reverendo padre abate in cercarlo mai l’ha potuto ritrovare e leggo di più che era di famiglia e di casata aldobrandesca; vorrei che sopra di ciò S.E. mi dicesse la sua opinione acciò mi confermasse e mi facesse palese gli sbagli del soggetto. Compatisca l’incomodo e si arricordi che il maggior contento che possa ricevere è l’impiegarmi in qualche suo comando a fargli conoscere che io col cuore mio le dico:
Don Orazio Mazzei di Santa Reparata, Marradi a dì due 9embre 1733
Ma perché tanto accanimento? Come mai il monaco vallombrosano Orazio Mazzei sosteneva le ragioni del camaldolese Guido Grandi? Per semplice amore della verità? Don Diego Colombari da Forlì, abate della Badia del Borgo nel 1738 nel suo libro Ricordanze scrisse:
Insomma nel 1733 dentro il monastero della Badia del Borgo c’era un sommessa lotta per la nomina del nuovo abate e può darsi che il monaco Orazio Mazzei fosse partecipe di questa.
Fonti
Carteggi del padre camaldolese Guido Grandi, Bibl. Univ. di Pisa EVA Internet culturale
La storia della Badia del Borgo di Fuvia Rivola, Livietta Galeotti e Teresa Montuschi