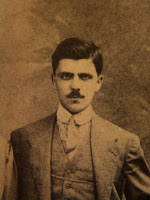Una visita all'ultima dimora
di Dino Campana
di Claudio Mercatali
La villa di Castelpulci è antica. Nel Cinquecento era di proprietà della famiglia Soderini, accanitamente antimedicea, che fu espropriata di ogni avere dal granduca Cosimo I. Alla fine del secolo la villa passò ai Riccardi, ferventi sostenitori dei Medici, che la ingrandirono fino alle dimensioni attuali. Ne furono proprietari per quasi due secoli e poi, a causa dell' elevatissimo tenore di vita, si riempirono di debiti e persero tutto. L'edificio, dopo varie vicissitudini, passò al demanio granducale e a metà Ottocento qui fu aperto un manicomio, che cessò nel 1973. Da allora fino ad oggi il palazzo è rimasto vuoto e quasi in abbandono. Ora la Provincia di Firenze, proprietaria, ha finito il restauro per destinarlo a sede della Scuola Superiore di Magistratura.
Per festeggiare l'evento il complesso edilizio è stato aperto al pubblico due giorni, a metà settembre, con tanto di visita guidata. Questa è stata una ghiotta occasione, non tanto per la storia dell'arte, ma perché a Castelpulci fu internato definitivamente Dino Campana, che vi rimase quattordici anni, fino alla morte.

Ecco com'è andata. La gente è tanta e c'è un servizio navetta fino in cima al colle. Percorriamo lo scenografico viale d'accesso, detto "Il Viottolone" e una vecchina racconta che da piccola vedeva spesso passare un traino con due cavalli, con i finestrini sbarrati, e sua mamma le diceva che era "la carrozza dei matti" che portava i pazzi al manicomio.
Forse anche Dino Campana arrivò così, perché nel 1918 i veicoli a motore erano pochi e soprattutto per i signori. La navetta ci lascia proprio sul piazzale e la villa si rivela ancora più imponente di quanto pareva vista da lontano.
Il Viottolone oggi e nel Seicento.
Dentro è pieno di gente e c'è da aspettare, ma qui non ci si annoia di certo, perché dal terrazzo sul giardino si vede un panorama esagerato, su tutta la piana di Firenze, fino a Prato.
La visuale spazia verso ovest e verso est senza nessun ostacolo e il risultato è quello che si vede nelle foto qui accanto. Le terre ai piedi del colle erano quasi tutte di proprietà della famiglia Riccardi, che dunque in questo modo dava dimostrazione agli ospiti della sua ricchezza.
Adesso tocca al mio gruppo ed entriamo nell' atrio, dove passavano i dottori e anche i ricoverati al ritorno dai lavori nei campi. Alla fine del lungo ed elegante corridoio, chiamato "Il Recetto" c'è una porta con una scritta molto chiara "Sezione degli uomini" e da qui entriamo nell' ex ospedale psichiatrico.
Dino Campana varcò questa soglia il 28 gennaio 1918, proveniente dal manicomio di S.Salvi, dove era stato internato in osservazione per quindici giorni.
A sinistra: Il corridoio del Recetto.
Sotto: L'ingresso della Sezione degli uomini.
Clicca sulle immagini
se le vuoi ingrandire
Dal Recetto si arriva al chiostro interno, che era il cuore della struttura.
Com'era fatto l'ospedale? Non c'erano celle, le camere erano quasi tutte multiple, molto luminose ma senza servizi, come d'uso all' epoca. Poco mobilio, in ferro, una ciotola e un bicchiere di latta.
L'ex Refettorio è ora ristrutturato completamente e sarà la sala da pranzo per la nuova Scuola di Magistratura.
Come passava le sue giornate Dino? Negli anni Cinquanta il giornalista Sergio Zavoli venne qui per raccogliere informazioni e ne trovò tante, perché c'erano ancora dei ricoverati che avevano conosciuto il poeta. Le testimonianze furono pubblicate e sono un documento importante per chi studia questa fase della vita del poeta.
La guida ci dice che Campana disse di chiamarsi Dino Edison e questo episodio è riportato in tante pubblicazioni a dimostrazione che ormai aveva perso la coscienza di sé.
Sopra: Il Refettorio
A fianco: Alcuni dei ricoverati che conobbero
Campana intervistati da Zavoli
Però non è vero, in realtà Campana alternava momenti di lucidità a stati di confusione.
Il dottore che seguì Campana con maggior attenzione si chiamava Carlo Pariani. Non era il suo medico curante ma ebbe diversi colloqui con il poeta perché pensava che ci fosse un legame stretto fra la genialità e la follia e cercava dati per dimostrare questo suo teorema. Scrisse il libro "Vite non romanzate di Dino Campana scrittore e di Evaristo Boncinelli scultore", che è un'altra fonte documentaria importante.
Dal libro si ricava che il poeta aveva una malattia neuro psichiatrica grave, a fasi alterne, ma ebbe sempre la percezione dello spazio, del luogo in cui si trovava e riconosceva le persone. Il dottore lo fece parlare molto e riuscì a fargli dire diverse cose sulla sua attività poetica. Una volta, nel 1928, gli mostrò una copia della nuova edizione dei Canti Orfici stampata da Vallecchi di Firenze e Campana si lamentò per le inesattezze. Gli studi di Pariani sono stati per tanto tempo oggetto di discussione e di critica. Qui di seguito c'è un articolo de La Stampa che parla di questo.
Carlo Pariani, il suo libro, l'edizione dei Canti Orfici del 1928 (copertina gialla) e l'edizione originale del 1914 (in piccolo).
Campana morì il 1 marzo 1932 di "setticemia primaria acutissima" cioè per una febbre molto alta che gli veniva dall'infezione di una ferita che probabilmente si era procurato cercando di scavalcare un filo spinato.
A fianco: 2 marzo 1932 La Direzione del Manicomio comunica al podestà di Marradi che Campana è morto il giorno precedente.
Fu sepolto poco distante, nel cimitero di S.Colombano, e poi nel 1942, per interessamento di Piero Bargellini, la salma venne traslata a Badia a Settimo, lì accanto, nella cappella sotto al campanile della chiesa di S.Salvatore. Alla cerimonia erano presenti le autorità e il gerarca Bottai. Però nell' agosto 1944 i Tedeschi in ritirata minarono il campanile, che crollò sulla cappella e la distrusse.
Sopra: la chiesa della Badia a Settimo
prima del 1944 e oggi, con il campanile
ricostruito in un'altra posizione.
A fianco: la tomba di Dino Campana, lungo
la navata sinistra della chiesa di S.Salvatore
Quotidiano La Stampa
1 febbraio 1995
articolo di Mario Baudino
Di recente il professor Stefano Drei,
di Faenza, ha scoperto che la persona
ritratta in questa foto non è Dino Campana