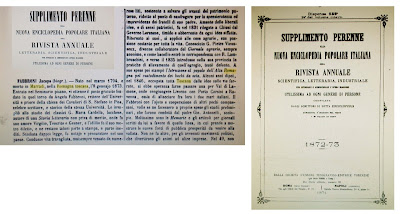sul Giornale Agrario Toscano del 1835
ricerca di Claudio Mercatali
Chi era Jacopo Fabroni? Questo nome nella famiglia fu
ripetuto almeno sei o sette volte nei secoli, secondo l’uso di dare ai discendenti
il nome di qualche antenato. Il Nostro nacque alla fine del Settecento, visse
sempre a Marradi nel suo palazzo di Piazza Scalelle, assieme ai suoi numerosi
parenti.
Era un notaio, appassionato delle cose del suo paese, con cento
interessi, ottimo scrittore, ottimo oratore. Lo storico Antonio Metelli cita un
suo comizio fatto dal balcone di piazza Scalelle nel 1848, intriso di fervente
patriottismo. Se ne potrebbero dire tante di lui ma è meglio fare riferimento
alla biografia della Nuova Enciclopedia Popolare Italiana, pubblicata dai suoi contemporanei, che ne sapevano di più.
Leggiamo:
Clicca sulle immagini
se vuoi una comoda lettura
... I suoi scritti, sono in buona lingua, briosi di gioventù, facili e piani ed attraggono il lettore, pieni di utili verità; onde riescono vantaggiosi a consultarsi. Oggi sono sparsi, e facilmente soggetti all' oblio, perché pubblicati senza nome. Ma se in Marradi vi saranno persone cui stanno a cuore le glorie paesane, faranno opera degna se le rintracceranno tutte ...
Adesso Jacopo ci interessa per una corrispondenza con Raffaello Lambruschini, agronomo di fama, membro del Gabinetto Vieusseux di Firenze, a proposito della coltivazione dei bachi da seta che, secondo il Fabroni, a Marradi si potrebbe migliorare parecchio ...
Vincenzo Dandolo, di cui il Fabroni dice nel suo articolo, era un agronomo veneziano, ideatore di nuove tecniche per allevare il baco da seta.
Il bombix mori, più noto come baco da seta, è un insetto che compie la metamorfosi dentro un bozzolo filato da lui stesso e diventa una farfalla dal buffo aspetto ...
La fabbricazione della seta nel Medioevo era un segreto industriale cinese che, secondo il mito, fu carpito da Fra Giovanni da Pian del Carpine che portò in Europa alcuni bozzoli nascosti nella canna del suo bastone.
Fra Giovanni aveva saputo che il Bombix è monofago, ossia mangia solo le foglie di gelso e muore se gli viene data qualsiasi altra foglia. Il segreto era appunto questo e il frate malfidato portò nel suo bastone anche i semi del gelso, che era una pianta sconosciuta qui da noi.
Nonostante i nostri sforzi bisogna ammettere che tutt'oggi le migliori sete sono quelle cinesi e giapponesi. Nel Novecento in Europa le filande fallirono quasi tutte con l'avvento delle fibre sintetiche.
La prima fibra sintetica venne fabbricata dalla multinazionale Pont de Nemours nel 1937, americana ma fondata nell' Ottocento da un francese. Si chiamava Nylon 6,6 e la sua commercializzazione fece chiudere tutte le filande. I suoi inventori, entusiasti, le diedero questo nome che è l'acronimo i Now You Lose Old Nippon (Ora hai perso vecchio Giappone) perché erano convinti di aver scoperto un sostitutivo della costosa seta. Oggi noi sappiamo bene che non è così perché le magliette di Nylon non traspirano e se sono al 100% portarle è un patire.
Per altri scritti di Jacopo Fabroni sul blog
12.04.2020 J.Fabroni sul Giornale Agrario Toscano (tematico Scienze Agrarie)
12.04.2020 La manomorta ecclesiastica (tematico )
02.08.2019 I miglioramenti di un fondo alpino (tematico Scienze della Terra)
17.11.2018 J.Fabroni descrive la Romagna Toscana (tematico La Romagna Toscana)
28.02.2017 J.Fabroni eclettico signore dell' '800 (tematico I Marradesi dell' '800)
20.03.2013 Gli affreschi di Palazzo Fabroni (tematico Gli affreschi)