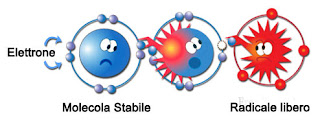Una nuova risorsa
per la medicina del futuro
Daniele Bani,
Ordinario di Istologia
ed Embriologia al Dipartimento di medicina
sperimentale e clinica dell' Università di Firenze.
sperimentale e clinica dell' Università di Firenze.
Lezione
all’auditorium
del Liceo Giotto Ulivi tenuta il 20.02.2017
Ernst Haeckel
Ernst Haeckel (1834- 1919) coniò il termine “staminali”,
Stammzelle, derivandolo dalla parola stame (è il filo dell’ordìto) unita alla
parola cellula, ossia piccola cella. Infatti aveva ipotizzato che tutte le
cellule specializzate presenti nei vari tessuti dovevano avere un precursore
comune, così come da uno stesso filo si possono fare diversi tessuti. Aveva anche affermato che la prima cellula che si forma dopo la
fecondazione, lo zigote, è la matrice di tutte le cellule del corpo umano. Tutto questo poi
si è rivelato vero.
Lo zigote è instabile e subito dopo la fecondazione che lo
ha originato, si divide e si ridivide a metà. Si formano due blastomeri, poi
quattro, otto, sedici nel giro di tre giorni circa. La cellula iniziale era
indifferenziata e i blastomeri anche. Perciò si chiamano cellule totipotenti (=
possono fare tutto).
Però al quinto giorno
avviene
una spartizione:
L’azione di una speciale proteina provoca una modifica nella
cellula totipotente, che diventa un trofoblasto,
cioè una cellula in grado di formare l’organo di collegamento del feto con la
madre (la placenta) e non altro. Nello stesso tempo un’altra proteina forma un embrioblasto, cioè una cellula che dà
origine gli organi interni del feto, ossia il sistema gastro enterico.
Ecco dunque che siamo
arrivati al primo bivio:
il trofoblasto e l’embrioblasto non sono più totipotenti,
ma pluripotenti (= fanno molte cose ma
non tutte). La cosa va avanti e per successivi bivi le staminali diventano
sempre meno generiche, fino ad arrivare alle unipotenti, come quelle della
pelle, che possono generare solo le cellule dell’ epitelio.
Fermiamoci un attimo:
Le cellule totipotenti si differenziano e danno tutte le
altre cellule ma da sole non possono dare un individuo nuovo. I biologi
spiegano che per questo serve in aggiunta il citoplasma di una cellula uovo,
che ha le proteine necessarie allo scopo. La cosa fu chiara quando si riuscì a
clonare la mitica pecora Dolly:
1) Una cellula uovo prelevata da una pecora venne privata
del nucleo.
2) In essa fu iniettato il nucleo di una cellula presa dalle tette di un’altra pecora.
3) Il tutto fu iniettato nell’utero di una terza pecora, che
portò avanti la gravidanza.

Dunque la clonazione è efficace per generare delle cellule staminali ma inevitabilmente esse partono dallo stadio adulto, perché derivano da un individuo che ha già vissuto una parte della sua vita. In altri termini, la pecora Dolly visse circa quanto sua madre, perché era stata generata dalle sue cellule già un po’ vecchie.
Come si riproduce una
staminale?
Quando una cellula staminale si riproduce può generare due
cellule anch’esse staminali o una staminale e una cellula differenziata,
che va a formare i vari tessuti.
Da questo derivano
delle conseguenze importanti:
1 Le staminali più “potenti” derivano da embrioni nei primi tre mesi di
vita.
2 Da embrioni di 3 – 6 mesi si ricavano le fetali, soprattutto dal cordone ombelicale.
3 Dal sangue si ricavano le ematopoietiche, che spesso sono
unipotenti.
Dunque le staminali sono più potenti e “utili” quanto più si
va indietro e ci si avvicina allo zigote.
E allora che problema
c’è? Prendiamole di li!
Ecco che sorge un problema etico, perché per molti non è
accettabile che una morula che proviene da un aborto sia usata per questo
scopo.
E allora cloniamo un individuo, così come abbiamo detto
prima, e smantelliamo la sua morula. In questo modo uccideremo un embrione, ma
ricaveremo delle cellule staminali utili per curare una persona, magari un suo familiare.
Qui il problema etico può essere più accettabile, però rimane notevole.
Infine una donna potrebbe donare il suo cordone ombelicale
dopo il parto, che all’ interno ha mezzo litro di sangue ricco di staminali. Questo
si ritiene accettabile se c’è il suo consenso scritto, perché il cordone
ombelicale, ormai inutile, sarebbe portato all’inceneritore dell’ospedale.
Che cosa si potrebbe
curare con le staminali?
I progetti sono tanti e quelli più prossimi alla
realizzazione sono: la cura dell’Alzheimer (la progressiva perdita delle
facoltà mentali negli anziani) il Parkinson (la perdita di funzionalità dei
movimenti, che all’inizio è comunemente nota come “palletico”) ma anche il
diabete, la distrofia muscolare …
Che cosa si cura
attualmente?
Non molto, soprattutto la leucemia e i tumori al sistema
linfatico. Al momento possiamo fare diverse cosa dalle cellule ematopoietiche,
che sulla superficie hanno la proteina CD34T che siamo in grado di riconoscere
e isolare. Perciò le possiamo separare da tutte le altre e mettere a coltura
“in vitro” cioè in provetta. Per questo è importante la donazione del midollo
osseo, che appunto produce le ematopoietiche. Sono interessanti anche le
multipotenti dei tessuti solidi (la cartilagine, l’osso, l’adipe e i muscoli)
che contengono cellule staminali dette MSC (del mesenchima).
Come si porta avanti
una ricerca medica sugli effetti delle staminali?
In campo medico, per accordo internazionale ormai accettato dai più, si usa
la tecnica “del doppio cieco” ossia
si cura un certo numero di pazienti somministrando alla metà di loro la terapia
e all’ altra meta un placebo, cioè una soluzione inefficace che non cura
niente. Dopo un certo tempo un’ altra equipe di medici, che non sa chi ha
ricevuto la terapia e chi il placebo valuta gli effetti, senza essere
condizionata né dalla indicazioni dei colleghi che l’hanno somministrata né
dalle impressioni dei pazienti.
Al momento il
progetto più importanti sono questi:
2)
Strimvelis = cellule staminali vettori
3)
Scots = degenerazione del nervo ottico
Il ricercatore giapponese Shinya Yamanaka ha ricevuto alcuni
anni orsono il Nobel per una procedura inversa di quella descritta fin qui, che consiste nel far
retrocedere una cellula specializzata fino alla staminale che l’ha generata,
con l’azione di proteine dette OC4, SOX2, NANOG, LIN28. Però qui siamo
ancora nel campo della ricerca pura perché questo scienziato ha lavorato solo
su cavie (topi).
......................................................................................................................................
Un po’ di te (Un futuro per tanti)
Incontro del 24.02.2017
Auditorium Liceo Giotto Ulivi
Pietro Frittitta
Reparto di Oncoematologia del Policlinico Careggi
Dr.ssa Myriam Mie,
Progetto Donazione sangue cordonale Osp.
Di Borgo San Lorenzo
Sintesi della relazione di Pietro Frittitta
Oggi è possibile la cura della leucemia e del linfoma per
mezzo del trapianto di midollo, che si può ricavare in diversi modi. Che possibilità ci
sono?
1)
L’allotrapianto
(da un donatore)
Il donatore potrebbe essere un famigliare di stretta
parentela, uno dei genitori, un fratello o una sorella. In questi casi ci può
essere una buona compatibilità, comunque da verificare con dei test preventivi.
Il donatore potrebbe essere uno sconosciuto, che ha accettato di donare il suo
midollo, oppure una donna che ha donato il sangue del cordone ombelicale.
2)
L’autotrapianto
Il midollo viene dallo stesso paziente, in un periodo di
remissione della malattia, o in momento di arresto dovuto alla chemioterapia.
Cioè si sfrutta una temporanea e provvisoria stasi del male che permetta il
proliferare di cellule sane nel midollo.
Si manifesta da propria volontà in un ospedale qualificato,
dal 18imo al 35imo anno di età. Si può donare fino a 55 anni. La prima caratterizzazione del midollo si esegue con un
prelievo di sangue. Si dona una sola volta (si può ripetere solo per mancato
attecchimento nel paziente ricevente). Si può essere chiamati anche dopo 20 anni.
Da dove si prende il
midollo?
1) dalle
creste iliache (dalle ossa del bacino) si può ricavare molto midollo. In questo
caso occorre una autodonazione preventiva, con sangue messo da parte in
precedenza, per ripristinare subito dopo le cellule del sangue del donatore,
finché non si riforma il suo midollo. E’ una operazione in anestesia spinale,
con un ricovero di circa due giorni.

2) Dalla circolazione periferica. Qui la procedura prevede una sollecitazione a produrre delle cellule sanguigne mediante farmaci, da somministrare nei giorni precedenti la donazione. Succede che l’eccesso di cellule sanguigne prodotte viene scaricato nel sangue e così si possono prendere con un prelievo da un braccio del donatore. Il sangue prelevato viene opportunamente filtrato in modo da trattenere le staminali emopoietiche e il resto viene reiniettato nell’altro braccio del donatore. Il tutto dura circa 4 ore.
3) Dalla
“donazione del cordone ombelicale”, come spiegato dalla dr.ssa Myriam Lie.
Per cominciare è bene chiarire che non si dona l’intero
cordone ombelicale ma il sangue contenuto nel suo interno al momento del parto
e quindi sarebbe meglio dire “donazione del sangue cordonale”. Il cordone ombelicale stabilisce un collegamento con la
madre, in modo che il feto riceve il sangue materno e scarica nella madre il
sangue da depurare, che contiene molte cellule staminali.
Infatti il feto, non essendo ancora un organismo ben
differenziato, contiene un gran numero di cellule indifferenziate. Dunque
interessa particolarmente il sangue in uscita, quello che passa per la vena
ombelicale, che è sangue del nascituro e non della madre.
Che cosa deve fare la
madre per donare?
Deve dare il consenso, che viene scritto nel libretto in cui
si scrivono i controlli, le visite e le cure che essa ha durante i nove mesi. Pochi giorni prima del travaglio deve accettare un controllo
per la verifica finale della sua idoneità.
Fino a qualche anno fa la madre accettava che un ago per i
prelievi togliesse il sangue dal cordone durante il parto, quando era in
posizione di parto. Però oggi questa procedura non viene più seguita, perché
creava apprensioni ed era inutile.
Dal sangue cordonale si ottengono molte staminali, che si
possono conservare nelle cosiddette Banche del sangue, che sono presso i
maggiori ospedali. In Italia non è ammessa la conservazione presso cliniche
private. Qui da noi non è permessa la donazione autologa, cioè il prelievo di
sangue cordonale da mettere in conservazione per un eventuale uso in favore
del nascituro, nel caso che ne avesse
bisogno da ragazzo o anche da adulto.
Fonte: Progetto Cellule staminali, del Liceo Scientifico Giotto Ulivi di Borgo san Lorenzo. Ideato dalla prof. Sabina Mazzoldi, curato dalla prof. Cristina Carlà Campa. Le illustrazioni e il testo di questo post sono del prof. Claudio Mercatali.