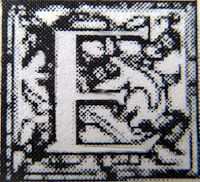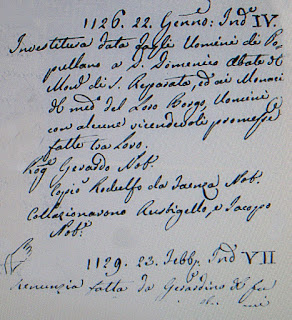nel territorio di Marradi
Ricerca
di Claudio Mercatali
La
Corte medioevale era l'insieme di edifici da dove il Signore del luogo controllava
il territorio. L’ economia curtense che si sviluppò in questi
insediamenti fu soprattutto agricola, chiusa, di pura sussistenza, con la plebe
sottoposta a regole penalizzanti a favore del padrone. La struttura urbanistica aveva dei
canoni precisi: in posizione prevalente c’era il castellare e nei pressi le
stalle, i granai, i magazzini, le umili case dei servi, un molino e una
chiesetta. Di solito vicino al castellare e in posizione sottostante c’era la
casa del fattore, spesso fortificata perché questa persona non sempre era
amata.
Lui decideva la ripartizione dei raccolti, lo stoccaggio delle derrate,
la gestione dei magazzini e a volte anche la definizione delle controversie. Il
nome deriva infatti dal verbo latino facio, e significa “colui che
fa”. Al Dominus spettava un terzo del raccolto più un certo numero di
giornate lavorative gratuite sui suoi territori. C’era anche una parte di
terreno incolto, di boschi, torrenti e prati, dove si poteva cacciare e pescare.
LE CORTI A
MARRADI
Non è chiaro
come fosse ripartito il territorio di Marradi nell’anno Mille o prima e non si
sa quante Corti vi fossero. Di certo molte, controllate dalle famiglie
Ubaldini, Pagani e Guidi spesso imparentate fra loro con una serie di matrimoni
d’amore o di comodo nei quali è difficile orientarsi. In linea di massima gli
Ubaldini controllavano il territorio verso le alte valli del Senio e del Lamone,
i Pagani signoreggiavano nella zona di Gamberaldi e Badia di Susinana e i Conti
Guidi nelle terre della valle Acerreta fino a Modigliana e oltre. Però questi
territori cambiarono spesso in estensione, a seconda della fortuna di queste
famiglie.
LE TRACCE
NEI NOMI
La Corte era divisa in:
1) Pars
dominica coltivata dal Dominus, che naturalmente era la
migliore. Forse il nome del podere Cà Dominici (al confine con
Brisighella dalla parte di Galliana) deriva da questo.
2) Pars
massaricia, gestita dai contadini e divisa in mansi, cioè in porzioni di
un quarto di ettaro dove il servo aveva l’obbligo di risiedere.
Manso è infatti
una parola derivata dal latino manère, rimanere, e ha dato origine qui
da noi ai cognomi Manenti, Manetti, Massari e ai toponimi Prati di Mansalto
(oltre Prato all’albero, a Casaglia), Masseto (a Crespino) Mansino (a Lutirano). Il Signore si circondava
di amici, protetti e guardie, i cosiddetti drusi o vassi e queste figure hanno
lasciato traccia nella toponomastica di Marradi: il Drùdolo (podere a Camurano)
era del “piccolo druso”, Boldrùda (Popolano) era il podere della serva e la
vigna della Vassanàra (a Cardeto) era di un servo del signore del Castellone.
LE CORTI DI
SANT’ADRIANO
E POPOLANO
Questa zona
ha molte caratteristiche che ricordano la Corte medioevale. A sant’Adriano ci
sono le rovine e la memoria del castellare di Benclaro, in un poggio
sovrastante, la casa torre del fattore o del Dominus al podere Casa Cappello,
il molino, la chiesetta, un nucleo antico di edifici che si vedono nella
cartografia del Cinquecento.
Anche a Popolano c’era un castellare e sulle sue
rovine venne poi costruita la chiesa e il campanile. C’era anche un molino, che
nella cartografia del Cinquecento è a ruota, una soluzione insolita
qui da noi. Oltre a queste notizie c'è un certo numero di documenti che parlano della vita nelle corti medioevali:
Decimo
secolo
Nelle carte
Rossini della Biblioteca Comunale di Faenza c’è il rescritto di un contratto
del 12 febbraio 909 per la concessione a livello (in affitto) di alcuni terreni
alla Badia di Campora, in cambio di un canone e di una prestazione d’opera
gratuita a favore dell’Arcivescovado di Ravenna, proprietario della Corte di
Sant’Adriano.
Undicesimo
secolo
Dai contratti
antichi dell’archivio Diplomatico di Firenze sappiamo che i monaci della Badia
del Borgo controllavano la zona di Marradi fino a Popolano e Sant’Adriano.
Il 6
ottobre 1025 i monaci chiesero al conte Guido di
Modigliana di difenderli: "Promessa fatta dal Conte Guido Guerra a
Donato abate del Monastero di S.Reparata di difendere il Castello di Marato
nelle di cui coste esistevano tre mansi ed una casa del monastero". Rogato
da Gerardo notaro.
Il 6 marzo
1072 i monaci stipularono un altro contratto interessante, trentennale, di
enfitéusi: "Conferma di livello (=
affitto) per ventinove anni alla volta di un manso di terra posto in luogo
detto Rio Cavo (è forse l’attuale podere Valcava, a Popolano) fatto da Guido
del fu Corbulo Accio prete monaco ed abate del Monastero di S.Reparata, la
quale terra era già stata data a livello dal predetto Corbulo al suddetto
Monastero col canone di otto moggia di lino, sette manne, tre brocche di vino,
un quarto di grano mondo, un pollo e altro". Rogato da Adalberto notaro.
Dodicesimo
secolo
Il Comune di
Faenza faceva parte della Lega di Pontida in quanto alleato di Bologna. Dopo la vittoria di Legnano contro
l’imperatore Barbarossa e la conseguente Pace di Costanza nel 1183 i comuni
della Lega si affrancarono dai vincoli con il Sacro Romano Impero, ma la cosa
non fu gratis. L’imperatore pretese un canone di 2000 lire all’anno che i
liberi comuni, volenti o nolenti, si dovettero accollare. Anche a Faenza toccò
una parte dell’onere e naturalmente lo caricò sui cittadini e gli abitanti
della valle, che si ribellarono. Dal Chronicon di Agostino Tolosano, uno
storico faentino dell’epoca, apprendiamo che i cavalieri faentini arrivarono
minacciosi a Sant’Adriano e assalirono il podere Montebello, dove però furono
sopraffatti dall’ira dei santadrianesi che non volevano pagare. Il fatto è
raccontato nel post indicato nella bibliografia qui sotto. Ora interessa notare
che fra i padroni della media valle oltre l’Arcivescovado di Ravenna e i monaci
della Badia del Borgo compare l’aggressivo Comune di Faenza, visto che era in
grado di pretendere i tributi.
Nel 1302 morì
a Casa Cappello il feudatario Maghinardo Pagani, fondatore di Brisighella,
signore pro tempore di Faenza e per tradizione di famiglia feudatario alla
Badia di Susinana. Nella seconda metà del ‘200 era stato il principale signore
della valle. Per chi ne vuole sapere di più c’è una bibliografia in fondo a questo
articolo. Ora interessa notare che il Dominus era cambiato di nuovo e il Comune
di Faenza in questo tempo ebbe solo in parte in controllo del territorio.
Quattordicesimo
secolo
Nella prima
metà del Trecento si instaurano a Marradi i Conti Manfredi, parenti e rivali
dei Manfredi di Faenza. Dominavano fino al castello di San Martino in Gattara e
controllavano la piana di Sant’Adriano. Giovanni Manfredi, suo figlio Amerigo,
e suo nipote Ludovico governarono fino al 1428 con una lunga serie di alti e
bassi, com’era di regola in quei tempi.
Il Castellone di Marradi nel primo Novecento
Quindicesimo
secolo
Nel 1428 i
Fiorentini conquistarono il Castellone di Marradi. Il commissario
Averardo de’ Medici assunse il comando delle operazioni e l’assedio si concluse
in un mese. Dai suoi diari, che sono conservati all’ Archivio di Stato di
Firenze, risulta che non fu semplice convincere gli abitanti di Fiumara e di
Scola (Popolano e Sant’Adriano) a prestare giuramento a Firenze abbandonando il
tradizionale legame con Faenza.
LA CORTE DI
SAN MARTINO IN GATTARA
Anche la
zona di San Martino ha le caratteristiche di una Corte. In cima al poggio c’era
un vero e proprio castello, ancora visibile nella cartografia del ‘500 dell’Archivio
di Stato di Roma, una chiesa antica e il Molino di San Zeno. E’ probabile che
questa Corte fosse distinta da quella di Sant’Adriano, perché aveva un proprio
castello in posizione dominante, di fronte a Benclaro e di solito un Dominus
per evidenti ragioni di comando non consentiva che nel suo territorio ci
fossero due fortilizi.
Lo
storico faentino del ‘200 Agostino Tolosano nel Chronicon dice che il “Castrum
Gattariae” ai tempi suoi era della Chiesa, concesso a un certo Amatore, figlio
di Ugolino di Teodorico. Nel 1216 i faentini, stanchi dei suoi soprusi, lo assalirono
e distrussero le due alte torri. Fu ricostruito e passò a Fantolino di
Albertino degli Accarisi. Lo storico Cavina scrive che nel 1289 il castello fu
venduto a Maghinardo Pagani che lo lasciò in eredità alla figlia Francesca, che
non seppe governarlo e lo vendette ai Manfredi di Faenza. Secondo il censimento
del Cardinale Anglic (1371) il Castrum aveva otto Focularia (famiglie) e un
castellano. Nel 1376 il fortilizio fu venduto al comune di Firenze che ne diede
il comando ai Manfredi del ramo di Marradi. Pessima scelta perché essi, in
lotta continua con i cugini Manfredi di Faenza, lo cedettero a loro in
occasione di qualche compromesso, scatenando la collera dei Fiorentini. Secondo
la corrispondenza di Giovanni Manfredi conservata all’Archivio di Stato di
Firenze questa accusa fu la ragione per cui nel 1428 il conte Ludovico
Manfredi, ultimo signore di Marradi fu imprigionato nel carcere fiorentino
delle Stinche e mai più liberato. Tutti questi passaggi incidevano poco sulla
vita e il benessere degli abitanti, perché i contratti servili più o meno erano
gli stessi indipendentemente da chi comandava al castellare.
LA CORTE DI
SAN CASSIANO
C’era una Corte
anche qui, con il castello ancora visibile sopra al paese, il molino, la chiesa
e ottimi poderi da grano, come Torricella e Camminatella. Il confine con San
Martino all’epoca era circa al podere Loiano, che ancora oggi ha una bella
torre tonda che compare un una cartina del ‘600. Il territorio si estendeva
nella valletta di Boesimo con un confine torto che poi provocò una disputa
secolare fra lo Stato Pontificio e il Granducato, risolta bonariamente solo nel
‘700. Il castrum Sancti Cassiani nel Medioevo fu soggetto alle solite
guerriglie: nel 1292 era della famiglia Fantolini ma fu assalito dall’
immancabile Maghinardo Pagani e Alessandro dei Conti Guidi di Roména (una
località del Casentino), marito di Caterina Fantolini cercò di difenderlo, però
Maghinardo profittò di una siccità e nel giro di poco lo espugnò e lo demolì. Ricostruito
nel 1321 da Francesco Manfredi, nel 1368 si arrese alle truppe pontificie
condotte dal cardinale Anglic. Nel 1413 l’antipapa Giovanni XXIII lo concesse a
Ludovico Manfredi, ma nel 1432 se ne impossessò Galeazzo Manfredi, conte di
Faenza e poi rimase sempre sotto lo Stato della Chiesa. (da Rocche e Castelli
di Romagna di AA.vv.)
Tutte queste
intricate vicende cessarono nel 1428 quando il territorio di San Cassiano e San
Martino passò definitivamente alla signoria dei Manfredi di Faenza e i
territori di Marradi, Modigliana e Tredozio passarono sotto Firenze.
In questi
comuni i castellari e i fortilizi delle Corti furono demoliti. Era un gesto dal
preciso significato politico: la Città non governava come facevano i signorotti
arroccati sui cocuzzoli ma con i Commissari della Signoria e i Gonfalonieri,
che risiedevano nel Palazzo Pretorio sulla piazza centrale dei paesi. Così
lentamente qui da noi si superò il Medioevo e finì l’organizzazione curtense
durata per tanti secoli.
Per
approfondire
Cerca nell'indice cronologico del blog questi articoli oppure digita le parole in grassetto nella casella di ricerca, in alto a destra nella home page del sito.
Cerca nell'indice cronologico del blog questi articoli oppure digita le parole in grassetto nella casella di ricerca, in alto a destra nella home page del sito.
6 luglio 2018 La Badia di Susinana
16 luglio 2017 Campora di
sotto
10 giugno 2017 La Pace di
Costanza qui da noi
.