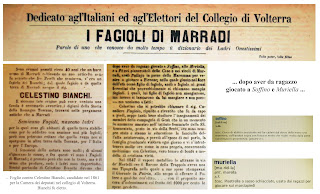Quando
l’attività umana lascia una traccia nei luoghi
Quando
l’attività umana lascia una traccia nei luoghi
Ricerca
di Claudio Mercatali
Il coltro è una specie di aratro.
Da questo viene il nome di Coltreciano.
un podere vicino a Marradi.
Nei
nostri monti spesso i siti prendono nome da qualche caratteristica collegata
alla loro natura. Li chiamarono così gli antenati, che con il duro lavoro nelle
campagne avevano avuto modo di constatare i fatti. Si potrebbe fare una ricerca
abbinando i posti con una certa caratteristica con il contrario, come:
Campo
lasso (a Santa Reparata) e il crinale delle Salde (oltre Gamberaldi)
Campo
al buio (Badia di Susinana) e Mirasole (Marradi)
Valérta (Badia del Borgo) e Valpiana (Popolano)
Oppure
cercare i poderi con il nome collegato alla loro resa agraria, come:
Zebarόla
(acerbina, Lutirano) e Val Zerbàra (Fantino).
 Schéta
(seccata, Albero), Lischéta (Val della Mèda) e L’Ischeta (Palazzuolo), poderi con il seccatoio per i marroni.
Zana
e Zanella, i poderi adatti per la frutta (la zana è un tipo di paniere).
Schéta
(seccata, Albero), Lischéta (Val della Mèda) e L’Ischeta (Palazzuolo), poderi con il seccatoio per i marroni.
Zana
e Zanella, i poderi adatti per la frutta (la zana è un tipo di paniere).
Però
lo scopo di oggi è la ricerca dei nomi derivati dal tipo di attività che veniva
svolta in certe zone, senza curarsi tanto della natura del luogo e della sua
resa agraria.
La
coltivazione con la marra
e il coltro
Attorno
al capoluogo la terra si lavorava con la marra, la zappa, nei campetti
terrazzati e da questo viene il nome Marato o Marradi. Il fatto è stato descritto
tante volte e quindi non importa soffermarsi ancora.
I campi di Coltriciano (sullo sfondo)
negli anni Sessanta
Però nelle vicinanze di
Marradi ci sono anche terre coltivabili in modo un po’ più agevole. Per esempio
Coltriciano di Sopra e di Sotto sono due
poderi sulla destra del Lamone, pianeggianti e con una buona resa, nonostante
il terreno duro e a tratti sassoso. Il nome deriva infatti da coltro, un
tipo di aratro che permetteva di non incidere troppo il terreno.
Da quanto
risulta dai Registri dei Censi del Seicento, che è nell’ Archivio storico del Comune,
qui c’erano molti lotti piccoli e indipendenti, non del tutto compresi nei poderi, proprio come se il sito fosse una specie di orto dei
marradesi.
 C'è un Coltreciano anche a Lutirano, vicino al Paese dalla parte di Badia della Valle.
C'è un Coltreciano anche a Lutirano, vicino al Paese dalla parte di Badia della Valle.
I
castagneti
Siamo nel paese del Marron buono e sulle colture castanicole è già stato
scritto tanto. Basterà ora ricordare che secondo l’uso locale un castagneto si
impiantava nei versanti a nord, a basȇn, a bacìno, a bacìo,
perché così si limitava il rischio della siccità estiva. C’è anche un detto per
questo: L’è l’aqua ed luj clà fa maturé i marǒ.

Prendiamo i poderi vicini
al capoluogo: i casi più tipici sono i Castagneti di Sasso e di Coltriciano, rivolti
nettamente a nord. Invece i poderi a solame avevano i castagneti staccati dal
resto della proprietà, in luoghi anche abbastanza lontani, purché rivolti a
nord ovest.
Se
ci allontaniamo dal capoluogo la situazione non cambia: tutti i castagneti di
Crespino sono orientati così, compreso il famoso castagneto di Pigàra.
A Casaglia si raggiunge il massimo: il paese è nettamente a solame e non
c’è nemmeno un castagno. Eppure i casagliesi campavano di castagne e di poco
grano, e i loro castagneti erano nella vallata accanto, quella di
Fornello.
Qui da noi un certo numero di località e poderi
prendono nome dalla parola “corno”. Ci
sono Corneta e Corneto (Palazzuolo). Il Corneto, Il Corno (Marradi), Le
Corniete (Crespino) il Passo del Corno o Corna (Modigliana). Non è possibile
che nella nostra zona ci siano "corna" da tutte le parti e
quindi serve una alternativa: i nomi potrebbero derivare dal tedesco korn,
grano, visto che l’appennino romagnolo fu abitato per due secoli dai Longobardi,
nei secoli più remoti del Medioevo. Infatti in ognuno di questi siti c'è
qualche campo pianeggiante e lavorabile, forse ottenuto per disboscamento al
tempo dei tempi, mentre tutto attorno i monti sono molto ripidi e coperti dalla
macchia.
Dal
grano e dalle castagne si ricavavano delle farine, per cui nel territorio
c’erano tanti molini. Le castagne e il grano si trasportavano a sacchi, con un
peso standard di una soma (135 Kg) da caricare sul somaro, che perciò si
chiama così. Tenute in conto anche la viabilità e le
pendenze nella Valle Acerreta era opportuno che ci fosse un molino ogni miglio (1600
m) perché tanti se ne trovano nel fondovalle, se si cerca bene. Qui sotto c’è l’elenco, dal confine con Modigliana all’Eremo di Gamogna.
 Vicino ai paesi i molini erano più fitti. Attorno al capoluogo in due miglia c'erano i molini di: 1) Ponte di Camurano 2) della Piazzetta di Biforco 3) di Casa Bernabei 4) della Concia, della Polvere, della Portaccia, con un unico canale
5) il Molino della Guadagnina, alla Badia e poi il Molinone, che era a cilindri. La ricerca completa in tutto il Comune fu fatta nel 2003 da Franco Billi e ad essa conviene fare
riferimento.
Vicino ai paesi i molini erano più fitti. Attorno al capoluogo in due miglia c'erano i molini di: 1) Ponte di Camurano 2) della Piazzetta di Biforco 3) di Casa Bernabei 4) della Concia, della Polvere, della Portaccia, con un unico canale
5) il Molino della Guadagnina, alla Badia e poi il Molinone, che era a cilindri. La ricerca completa in tutto il Comune fu fatta nel 2003 da Franco Billi e ad essa conviene fare
riferimento.
I
laghi
Laguna,
Pian di Laguna, Fosso del Lago, I Laghi (al confine con Vicchio), strada di
Lago (Modigliana) … ecco che la storia si ripete: com’è possibile che nelle
nostre montagne, specialmente in alto, ci siano tanti toponimi che parlano di
laghi e lagune?
Clicca sulle immagini
se le vuoi ingrandire
 In
realtà il toponimo lacus è da
intendere come lacuna, mancanza,
difetto di qualcosa e non come laguna.
Che cosa venne a mancare in questi siti? Molto probabilmente i poderi furono
ricavati per disboscamento e quindi la mancanza si riferisce all’ assenza di
alberi.
In
realtà il toponimo lacus è da
intendere come lacuna, mancanza,
difetto di qualcosa e non come laguna.
Che cosa venne a mancare in questi siti? Molto probabilmente i poderi furono
ricavati per disboscamento e quindi la mancanza si riferisce all’ assenza di
alberi.

Nel medioevo e anche dopo il disboscamento per ricavare terreni di
coltura era una pratica comune nell’ insediamento, un po’ come in una piccola
Amazzonia.
La
pastorizia transumante per tanti secoli è stata una attività svolta nelle alte
valli del Lamone, dell’ Acereta e soprattutto a Campigno. Il clima costringeva
i pastori a trasmigrare in inverno verso la Maremma, specie a
Roccastrada, dove si stabilirono tanti di noi lasciando una traccia ancor oggi
riconoscibile nei cognomi e in qualche lontana parentela.

Ecco che cosa dice
Jacopo Fabroni, un notaio marradese di metà Ottocento, appassionato cultore di
agricoltura delle nostre montagne.
Qualche nome? Val Pecora (Campigno), Vallagnello (Palazzuolo), Il Becco (Oltre il valico di Coloreto), Vello e Vallamento (Lutirano). Lamm in tedesco significa agnello.

I contratti livellàri di
Crespino
Il contratto agrario di livello
era già in uso nell’ Antica Roma, per dare in affitto delle terre secondo le
condizioni scritte in “duo libelli pari tenòre conscripti” (da qui il
nome del contratto): due libretti uguali e ciascun contraente firmava quello
che rimaneva in mano all' altro. Questi contratti furono usati molto
nel Medioevo anche dalle Badie come quella di Crespino, che davano in
concessione le loro terre a vario titolo. Il giurista Silvio Pivano agli inizi
del Novecento, li studiò e li definì così:
“Le Precàrie e i Livelli erano contratti
fra persone della più varia condizione sociale, che cadevano su beni di
qualunque entità e natura, erano di qualunque durata, con canone di
qualsivoglia valore e specie, con o senza obbligo di miglioramento dei fondi. Per
contro, nella grande varietà degli esempi, un elemento appariva costante e
sicuro, quello della forma con cui dovevano essere conclusi”.

La “forma” conclusiva nel nostro
caso era la definizione scritta o orale di un canone in natura o in prestazione
d’opera. Spesso il crespinese livellario
(= affittuario) della Badia era tenuto e prestare un certo numero di ore
lavorative in favore del monastero a seconda del suo mestiere. Nella seconda metà del Novecento, il contratto di
livello cadde in disuso e così gli assegnatari livellari non
pagarono più alcun canone. Però la maestra Giovanna Pieri, di
Crespino, racconta che suo nonno pagava ancora il livello ai signori Mazza, che
consisteva in un certo numero di presse ogni volta che tagliava il fieno. Il
Contratto di Livello a Crespino era sine die (perpetuo) e passava di
padre in figlio anche se la proprietà del terreno cambiava. I Mazza erano
diventati titolari del diritto livellario in virtù del seguente antico
acquisto.

Carlo Mazza, agli inizi
dell’ Ottocento sposò Rosa Bandini ed ebbe in dote una parte della Bandìta di
Crespino che la famiglia della moglie aveva comprato dai monaci nel Settecento,
quando la Badia chiuse per scarsità di vocazioni e divenne una semplice
parrocchia.

Il signor Remo Scalini, che diversi
anni fa comprò i Prati della Logre dai Mazza, estinse tutte queste servitù e
ora è proprietario a pieno titolo delle terre.
I
Prati della Logre sono di
fronte a Crespino dove c’erano delle partizioni livellarie. Il nome è
probabilmente una deformazione del romagnolo
Pré degl’Ovre ossia i prati
dove era dovuto un canone di prestazione d’opera a favore dei monaci della
Badia. Un altro caso è il sito degli
Ortacci, in quota vicino al confine
con il Comune di Vicchio, chiaro per il nome ma soprattutto per la suddivisione
delle terre in porzioni piccole e fitte, che si vedono bene nel Catasto
Leopoldino del 1822 qui sopra. La stessa cosa si nota nel sito detto
E forné,
lungo la Faentina Vecchia, prossimo alla
Font
de Rè (fonte del rio) che si vede bene nella moderna Carta della Agenzia
delle Entrate, assieme alla partizione della
Crocetta, sopra al paese.
Anche il Comune di Marradi aveva dei beni da concedere a livello, perché a seguito di un complicato contratto nel Cinquecento aveva ottenuto dai monaci di San Benedetto in Alpe dei diritti livellarii sui poderi del Becco e Valdimora del Becco. L'esazione del diritto passava da un proprietario all' altro in caso di vendita, come si può leggere in questo atto del notaio ser Giuseppe Cavina Pratesi. Dunque il signor Angelo Ferrini acquirente di queste terre nel 1833 dovette farsi carico della tassa.
Per
approfondire:
Vincenzo Roppo, Il contratto, Giuffrè, 2001, pp. 217-255
Franco Billi, I mulini del territorio di Marradi, nel Blog al tematico Scienze della Terra, 18.12.2013 (prima parte), 12.02.2014 (seconda parte), 15.03.2014 (terza parte).